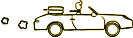Quiz dei lettori
Scelga la risposta giusta e partecipi all'estrazione nell'ultimo numero della rivista. Buona fortuna!


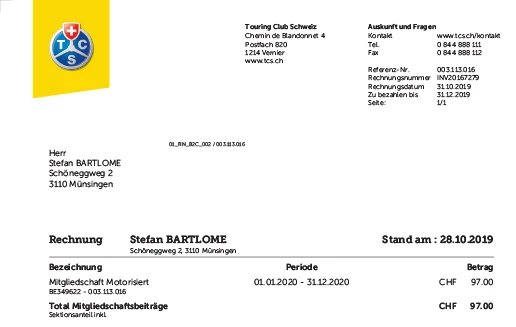
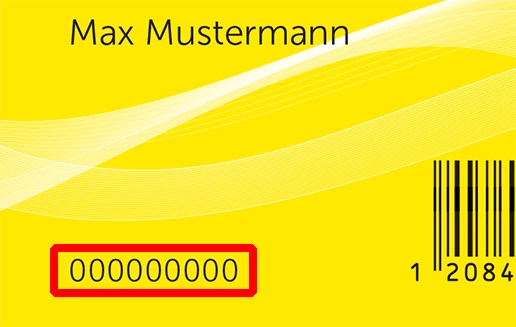
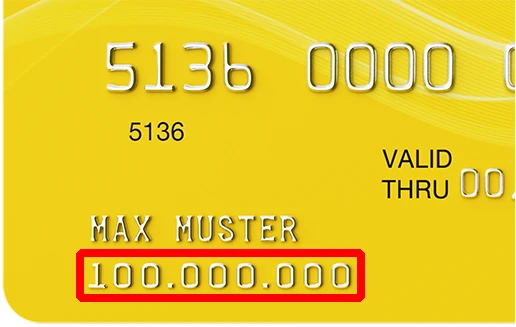
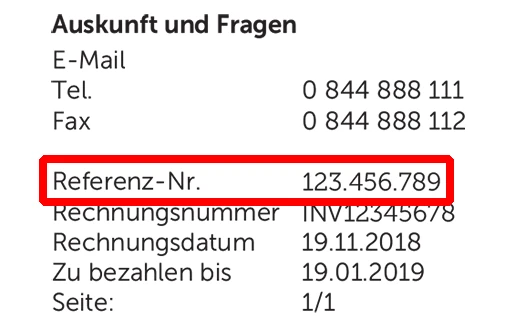
Intervista: Dino Nodari
Foto: Emanuel Freudiger
Su incarico del DATEC (Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni), il Politecnico federale di Zurigo, sotto la direzione del prof. Ulrich Weidmann, ha valutato e priorizzato circa 500 progetti di trasporto stradale, ferroviario e urbano da realizzare entro il 2045. Il programma «Trasporti ’45» mira a garantire che, in caso di risorse limitate, vengano realizzati i progetti che apportano i benefici maggiori alla mobilità, all’economia e all’ambiente. L’analisi ha fatto seguito alla bocciatura dei piani di ampliamento delle strade nazionali e al quasi raddoppio dei costi nel settore ferroviario. Weidmann ha basato la perizia su criteri quali l’efficacia, il rapporto costi-benefici, l’ecosostenibilità e l’importanza a livello regionale. Misure urgenti sarebbero necessarie in aree in forte crescita come Zurigo, il Lago Lemano e la Svizzera nord-occidentale.
Il rapporto sottolinea che, con le risorse disponibili, è possibile un ampliamento sostenibile, a patto che i progetti vengano coordinati, rinviati o ridimensionati. Stando al rapporto Weidmann, per il periodo 2025–2045 il DATEC prevede una spesa di 9 miliardi di franchi per le strade nazionali, di 14 o 24 (con la proroga dell’uno per mille dell’IVA) per i progetti ferroviari e di 7,5 per progetti d’agglomerato. Sulla base delle priorità definite per i progetti e alla luce degli obiettivi della politica dei trasporti, la perizia raccomanda un approccio focalizzato sulle grandi opere strutturalmente efficaci, integrate da ampliamenti mirati in settori critici della rete per quel che riguarda la capacità: i progetti di ampliamento strutturalmente efficaci permettono di ottenere miglioramenti orientati al lungo termine e alla solidità di pianificazione. Ciò crea nuovi margini di manovra per i decenni successivi. Alcuni progetti chiave eliminano le criticità in corrispondenza di punti nodali, migliorando così la capacità e la qualità dell’intera rete. Altri progetti prioritari rafforzano la resilienza e facilitano la manutenzione delle infrastrutture esistenti. L’analisi fungerà da base per le decisioni che il Consiglio federale dovrà prendere in merito ai finanziamenti e ai progetti di ampliamento. Le fasi di ampliamento concrete saranno riunite in un unico progetto da porre in consultazione l’anno prossimo.

Lei che ha proceduto a un attento esame del nostro sistema di trasporto, ci dica: siamo davvero sull’orlo del collasso stradale e ferroviario come talvolta si lascia intendere?
Ulrich Weidmann: Parlare di collasso è fuorviante perché implicherebbe la paralisi improvvisa di tutto il sistema. Direi piuttosto che lo sviluppo procede a rilento. È chiaro che, a causa della crescita demografica, soprattutto negli agglomerati, il traffico è spesso congestionato. E così pure gli itinerari alternativi si rivelano insufficienti. Se poi si verifica un incidente o nevica, improvvisamente si blocca tutto. Gli automobilisti danno prova tutti i giorni della loro abilità nel cercare il percorso alternativo migliore. Il sistema, per il momento, tiene ancora, ma sta diventando sempre più instabile e i quartieri residenziali ne risentono. Per quanto riguarda il traffico ferroviario, forse dobbiamo ammettere che, rispetto agli altri Paesi, siamo stati piuttosto «viziati» negli ultimi anni. Ritengo che a un certo punto dovremo accontentarci di un comfort leggermente inferiore, perché le possibilità di aumentare la densità della rete a breve termine sono pressoché inesistenti. Tuttavia, per convertire un maggior numero di pendolari al trasporto ferroviario, sono necessarie delle misure.
I sei progetti di ampliamento dell’autostrada bocciati alle urne sono all’origine della sua perizia. Stando alla sua analisi, solo due di quei progetti sono veramente prioritari. Gli altri quattro non sono quindi così importanti e urgenti?
No, sono importanti anch’essi, ma non urgenti. È una questione di prospettiva. Ci siamo concentrati sui lavori di completamento della rete di trasporto, sulle carenze del sistema e sui tratti esistenti per i quali è già previsto un ammodernamento imminente. Tra i sei progetti figuravano anche quelli di potenziamento della capacità, ai quali abbiamo assegnato una priorità più bassa per i prossimi vent’anni. Con la conversione delle corsie di emergenza o altre misure funzionali possiamo ottimizzare il sistema in tempi relativamente brevi.
Quindi, in realtà, non c’è fretta?
Nel rapporto abbiamo specificato che la nostra priorizzazione consente di guadagnare un po’ di tempo, ma che la situazione resta comunque urgente. Abbiamo indicato esplicitamente quali sono i tratti in cui dopo il 2045 sarà praticamente inevitabile intervenire con misure strutturali. Ma ci sono altri tratti in cui il trasporto pubblico può sopperire in parte alla domanda supplementare. Non c’è da aspettarsi un alleggerimento nel senso di una riduzione, ma piuttosto una stabilizzazione su livelli elevati.
Quanto sono importanti le autostrade nel sistema di trasporto?
Il trasporto privato rappresenta circa tre quarti del traffico totale. E la metà circola sull’autostrada. Insieme alle principali linee ferroviarie, le autostrade costituiscono il fulcro del sistema di collegamento. Ma quando si parla di autostrade si pensa spesso ai viaggi lunghi. È vero che svolgono anche questa funzione, ma non solo. A un esame più attento, si nota che il traffico autostradale è perlopiù regionale. Pertanto, le autostrade possono anche essere considerate come itinerari regionali veloci.
In che maniera hanno inciso tali considerazioni nella perizia?
Abbiamo proposto di riesaminare i due progetti autostradali della galleria sotto il Reno di Basilea e della galleria del Rosenberg a San Gallo che consentono di decongestionare la rete di trasporto urbana, alleggerendola non solo dal traffico a lunga percorrenza, ma soprattutto da quello a corto raggio. Ciò crea, a sua volta, un margine di manovra nella progettazione della rete di trasporto urbana e rappresenta un preinvestimento in future grandi opere di ammodernamento.
Dal 2019 le ore di coda in autostrada sono raddoppiate e non ci sono segni di un’inversione di tendenza.
La capacità della rete è uno dei criteri su cui ci siamo concentrati, ma, più che le ore di coda in sé, abbiamo considerato la stabilità del vettore di trasporto. Le code in autostrada creano instabilità nel funzionamento di tutta la rete di trasporto, perché il traffico di aggiramento viene dirottato su tratti stradali che non sono stati pensati a questo scopo. A medio termine prevediamo la conversione delle corsie di emergenza e l’impiego di misure funzionali, ma segnaliamo anche ai politici che, se le condizioni finanziarie lo permettono, in alcuni tratti è necessario intervenire. Ci sono anche tratti di cui, invece, potremmo fare a meno in vista dell’ampliamento della rete ferroviaria.

Attualmente si parla molto di digitalizzazione e automazione dei sistemi di trasporto. Queste tendenze sono state prese in considerazione nell’analisi?
Abbiamo esaminato il periodo che va dal 2025 al 2045. Nei prossimi vent’anni avrà luogo la fase di costruzione e solo nella seconda metà del secolo potremo parlare degli effetti: è in quest’ottica che abbiamo lavorato. Abbiamo già ipotizzato che, fino ad allora, si compiranno grandi passi avanti nella digitalizzazione e nell’automazione. Abbiamo tenuto conto di tali aspetti – e di tutte le speculazioni ad essi associate – più per il trasporto su rotaia che per la rete stradale.
Perché?
Laddove era in gioco il potenziamento della capacità, abbiamo potuto abbassare il livello di priorità dei progetti ferroviari anche perché prevediamo che entro il 2045 il trasporto su rotaia potrà essere in gran parte automatizzato.
Non è così per il trasporto su strada?
A questo proposito, sono onestamente ancora un po’ indeciso su quali saranno gli effetti della digitalizzazione, soprattutto in termini di capacità. Tali sviluppi avranno un grande impatto e molti vantaggi sulla sicurezza stradale o sul consumo energetico. Ma per quanto concerne la capacità, mi sembra che la situazione non sia ancora del tutto chiara.
A che punto siamo con l’automazione?
È in pieno sviluppo ed è già in parte integrata di serie nelle automobili o disponibile come optional. Ma anche in questo caso prevedo una trasformazione graduale, i cui effetti saranno tangibili solo nella seconda metà del secolo. L’automazione non arriverà di colpo.
Se si parte dal presupposto che anche il trasporto pubblico sarà automatizzato, magari anche con vettori più piccoli, ha senso convogliare il traffico verso i grandi hub o le stazioni dei centri urbani?
Laddove la capacità deve essere molto alta, come sulle linee ferroviarie suburbane dove si concentrano decine di migliaia di passeggeri al giorno, avere vettori più piccoli su strada o su rotaia non offre alcun vantaggio. Su tali tratte non c’è niente di meglio, in termini di capacità, che farli convergere in un unico vettore di grandi dimensioni. Si deve quindi continuare a utilizzare unità di grandi dimensioni, ma ottimizzandone il funzionamento. Ritengo, tuttavia, che si possano realizzare grandi cambiamenti nei collegamenti regionali. I veicoli autonomi potrebbero cambiare radicalmente la distribuzione capillare. L’ultimo miglio resta uno dei principali handicap del trasporto pubblico. Mi chiedo, infatti, se il treno sia ancora il mezzo di trasporto giusto. I veicoli autonomi potrebbero creare nuovi sistemi di navetta e migliorare notevolmente l’attuale modello park and ride: anziché andare a parcheggiarsi dopo l’arrivo in stazione, potrebbero continuare a circolare.
Altri Paesi sono più avanti in questo settore. Ci stiamo lasciando sfuggire un’opportunità?
Ho la sensazione che si potrebbe affrontare la questione con maggiore determinazione. Non nel senso che dovremmo sviluppare noi questi sistemi, la Svizzera è troppo piccola per farlo, ma siamo piuttosto cauti persino nel loro impiego. Probabilmente perché, da un lato, non ne intravediamo i vantaggi e, dall’altro, non siamo ancora pienamente consapevoli del fatto che la mobilità cambierà radicalmente e che molto probabilmente in futuro altri sistemi ci trasporteranno in modo più efficiente rispetto ad oggi. Ma oltre all’utilità e alla consapevolezza, ci vogliono anche investimenti consistenti.
Ciò vale anche per il trasporto su rotaia?
Sì, anche lì sono necessari ingenti investimenti iniziali, che in una prima fase saranno un costo supplementare, ma che consentiranno importanti risparmi in un secondo momento. Nel caso del treno, immagino qualcosa di simile al pilota automatico degli aerei. In determinati punti della rete subentrerà il pilota automatico, ma per molto tempo ancora ci sarà del personale in carne ed ossa sui treni.
In che ambiti sarà utilizzato il pilota automatico?
Per la capacità sono decisivi gli snodi, ovvero le grandi stazioni. Se si vuole potenziare la capacità, è necessario fare in modo che vengano usati con precisione gli slot giusti. Ora, questi slot cambiano continuamente. Tali sistemi devono interagire, calcolare costantemente gli slot ottimizzati e, allo stesso tempo, controllare il treno in modo da non lasciarsi sfuggire gli slot adeguati. L’uomo non è in grado di fare calcoli
del genere.
Dobbiamo quindi rassegnarci al fatto che per il momento le ore di coda continueranno ad aumentare e i treni ad essere sovraffollati?
Sarebbe falso dire che la situazione migliorerà. Prevedo che i prossimi dieci–quindici anni saranno piuttosto difficili e faticosi. Al di là di questo orizzonte mi aspetto che, piano piano, uno dopo l’altro, i progetti si concretizzino.
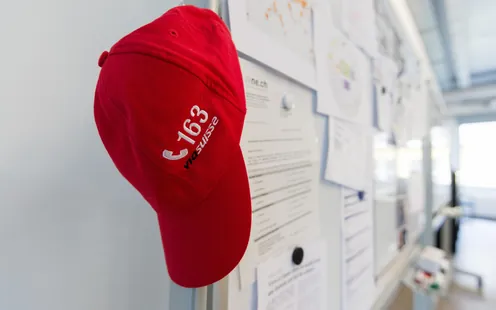
Attenzione, veicolo contromano!
Lo scorso anno alla radio sono state diffuse circa 150 segnalazioni di veicoli in contromano sull’autostrada.

Un fiume ricco di meraviglie
Durante una crociera sul Mekong, i passeggeri vivono innumerevoli incontri con la gente, la cultura e la vita lungo e sul ...

Prova Honda CB1000GT
Con un semplice movimento del polso, la Honda CB1000GT si trasforma in una sportiva scattante. Una sport tourer dal design moderno a un prezzo interessante.

Padre e figlio uniti dalla stessa passione
Michael (a sin.) e Matthias Hansen formano il duo di pattugliatori unico nel suo genere al TCS.